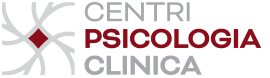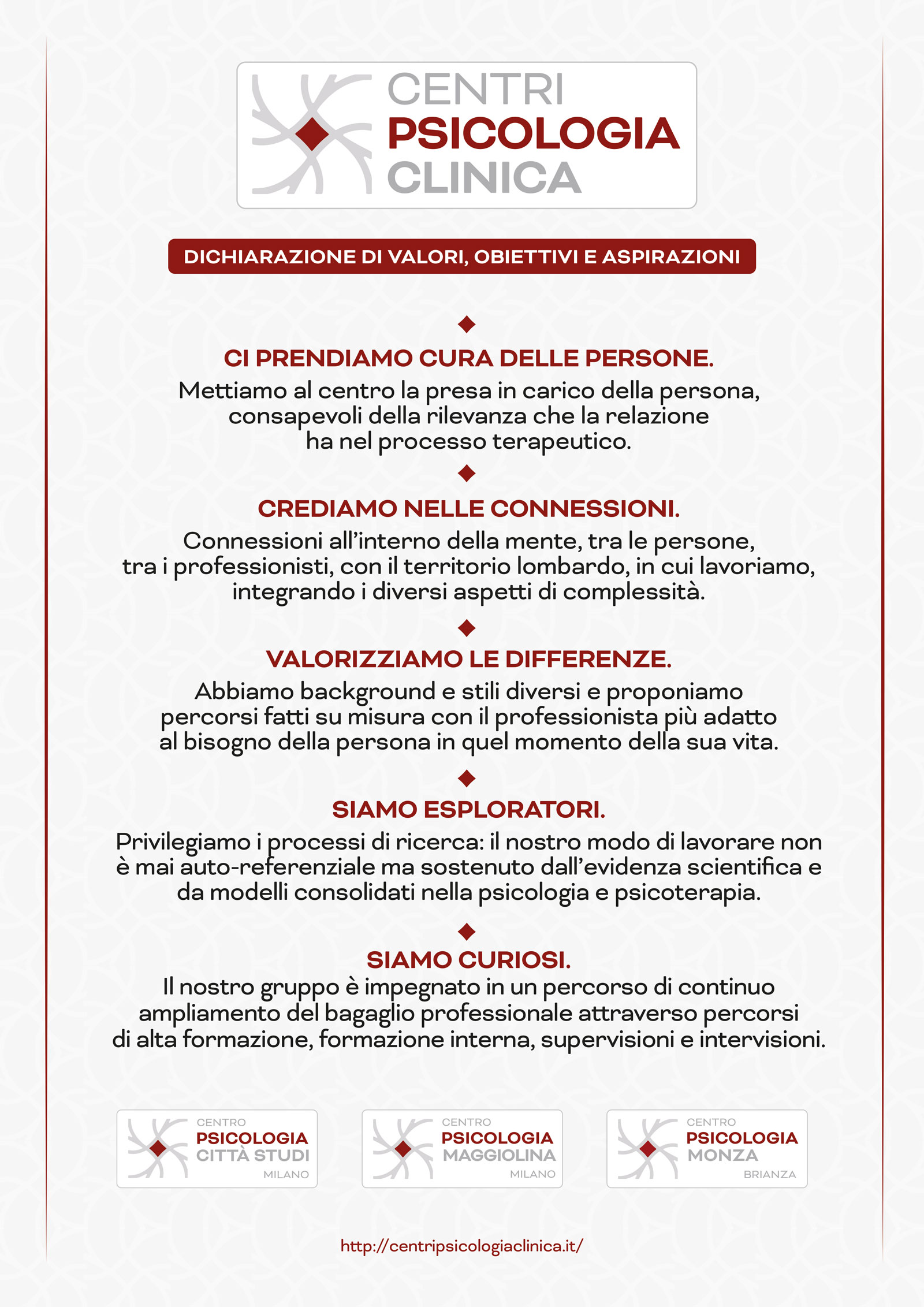La gravidanza è un lungo viaggio caratterizzato da numerosi cambiamenti corporei, psicologici e cognitivi che talvolta possono essere travolgenti e accompagnati da svariate sfumature emotive a volte contrastanti. Questo periodo di transizione e sospensione, per quanto in parte caratterizzato da tappe prevedibili, è vissuto da ciascuna donna e da ciascuna coppia genitoriale in modo unico e necessita di un tempo soggettivo di adattamento.
La mamma deve attendere nove mesi prima di incontrare e conoscere il proprio bambino. Un periodo così lungo di attesa è funzionale, dal punto di vista biologico, tanto al feto per la sua crescita, quanto alla futura madre per la maturazione delle sue competenze genitoriali. Tale tempo concede infatti di inoltrarsi nello sfaccettato processo di elaborazione di rappresentazioni mentali, fantasie, emozioni, desideri, sogni e affetti relativi al nuovo ruolo di sé e al proprio figlio, che si porrà come base del legame mamma-bambino.
I cambiamenti nell’identità: la nascita di una nuova parte di sé…
Nel momento in cui si scorgono le due linee sul test di gravidanza e spesso ancor prima, a partire dalla progettualità di avere un figlio, nella donna inizia ad affiorare una nuova parte di sé: quella di madre. L’integrazione di tale parte con le altre preesistenti richiede una ridefinizione della propria identità. Tale processo non avviene in un tempo definito, ma durante tutti i mesi precedenti e anche successivi alla nascita del bambino fino ad esitare in un “nuovo” senso di sé in continuità con il passato ma, allo stesso tempo, diverso.
Per alcune donne l’emergere della parte corrispondente all’“essere una madre” può essere accolta con particolare entusiasmo e piacevolezza, divenendo talora preponderante. Per altre può, al contrario, apparire inizialmente poco compatibile con pregressi aspetti di sé (l’essere una lavoratrice, una moglie, un’amica fidata o una figlia). La difficoltà nel conciliare e assimilare tali parti può attivare nella futura mamma una mescolanza di sensazioni: disorientamento, paura, rabbia e tristezza.
… E di qualche preoccupazione
Spesso accanto alle difficoltà di questa riorganizzazione psichica del mondo interiore si fanno largo alcuni timori: “riuscirò ad essere una brava mamma?”, “sarò in grado di prendermi cura del mio bambino?”. Queste e molte alte preoccupazioni possono aggiungersi all’incertezza dell’attesa, ma anche aprire un confronto diretto con la propria figura materna. Il diventare mamma crea un ponte tra futuro e passato: la relazione affettiva instaurata con le proprie figure genitoriali tende, infatti, a influenzare la rappresentazione che si costruisce di sé come madre (Cassidy et al., 1999).
A fronte di questa fase di “scombussolamento” può essere utile dedicare alcuni momenti della giornata a soffermarsi senza giudizio sui propri pensieri, immagini e vissuti interiori per diventarne più consapevoli. Questo atteggiamento serve ad accogliere tutte le emozioni, anche quelle negative, normalizzandole: anziché tentare di “eliminarle”, ci si può avvicinare con curiosità per esplorarle in tutte le sfaccettature.
I cambiamenti nelle priorità
Oltre al modo di pensarsi e di rappresentare se stesse, in gravidanza cambiano il modo di pensare i propri progetti sul futuro, lo stile di vita e le priorità. Per tutelare la salute del bambino, alla donna viene chiesto di modificare il proprio regime alimentare e di adottare uno stile di vita salutare (per esempio astenendosi dal fumo o dagli alcolici), ma anche di evitare le attività considerate “rischiose” per il feto, come alcuni sport o viaggi avventurosi. Tali limitazioni, percepite talora come perdite o rinunce alla propria libertà, possono essere difficili da accogliere, generando tristezza e frustrazione.
Questa fase di attesa è spesso caratterizzata anche da una riorganizzazione pratica degli spazi della casa per adattarli all’arrivo del bambino: la sua cameretta, le prime tutine e tutto l’occorrente. Questi riti concreti di “allestimento” favoriscono anche il processo di riorganizzazione psichica che consente di creare uno spazio interiore dedicato alla rappresentazione di sé nel ruolo genitoriale, del bambino e della coppia. Le attività di preparazione promuovono, inoltre, l’emergere di numerose fantasie che proiettano l’immaginazione del genitore a possibili future scene di vita quotidiana, spesso accompagnate da vissuti di curiosità e commozione, ma anche disorientamento e preoccupazione.
La comparsa di nuove responsabilità
Diventare genitori comporta un nuovo carico di responsabilità: accanto ai propri bisogni, compaiono quelli urgenti del bambino. Pensandoci, il futuro genitore potrebbe sperimentare paura, ansia, costrizione e angoscia. A ciò si associa, non di rado, la percezione di una limitazione della futura autonomia e soprattutto del tempo libero dedicato alle proprie passioni e interessi. Per esempio, è diffuso il falso mito secondo cui “le madri dovrebbero porre sempre al primo posto i bisogni del bambino”.
Ciò può indurre alcune donne ad annullarsi, trascurando completamente le proprie esigenze fisiche e psicologiche. In realtà, è bene avere a mente che se si ha cura del proprio benessere psico-fisico, si ha contemporaneamente cura del proprio bambino. In quest’ottica diventa dunque importante individuare i propri bisogni e dedicare del tempo alle attività che alleggeriscono tensione e stress, con risvolti positivi anche sul benessere del bambino in grembo.
I cambiamenti nelle dinamiche di coppia: il raggiungimento di un nuovo equilibrio.
La gravidanza e la nascita di un figlio, con l’allargamento dei progetti di vita da due a tre e i cambiamenti che ne derivano, alterano inevitabilmente l’equilibrio raggiunto dalla coppia. La fase di attesa, così come il periodo successivo al parto, saranno caratterizzati da sforzi e tentativi di assestamento di un nuovo equilibrio e di costruzione di una nuova relazione tra i membri della famiglia.
Accanto all’emergere della nuova identità di sé tende a cambiare anche la rappresentazione del partner: non più solo amante, ma anche genitore. Ciò può tradursi in un atteggiamento diverso, maggiormente accudente o al contrario distaccato. Il cambiamento corporeo della mamma e la sua sensazione di poter risultare non attraente, le frequenti oscillazioni del desiderio sessuale e il focus attentivo sul bambino in arrivo possono influenzare i rapporti intimi della coppia con ricadute sulla relazione. È fondamentale aprire dei momenti di confronto e condivisione in cui comunicare i propri vissuti relativi al rapporto di coppia, così da creare uno spazio in cui poter esprimere paure ed emozioni, aspettative, desideri e bisogni.
I cambiamenti del corpo: un nido per il proprio bambino
In gravidanza i cambiamenti del corpo sono certamente un aspetto non trascurabile. Il corpo si prepara ad accogliere una nuova vita: nel grembo, il neonato costruisce la sua casa e la mamma si mette a disposizione per renderla comodo e confortevole. Il corpo è in continua trasformazione, tanto che la futura mamma può avere la percezione di perdere il controllo su di esso ed essere impaurita nel vederlo modificarsi in modo irrimediabile, superando un punto di non ritorno oltre il quale non sarà più possibile riavere il corpo abitato per tutta la vita.
Scorgere la prima protuberanza della pancia può essere vissuto dalla mamma con orgoglio e gioia, percependolo come un evidente segnale dell’esistenza e della crescita del proprio bambino. Allo stesso tempo, può suscitare emozioni ambivalenti, imbarazzo e un senso di turbamento, sino a riattivare o acuire conflitti o disagi pregressi relativi alla propria immagine corporea. Così come per i cambiamenti descritti in precedenza, la donna si trova a costruire un nuovo rapporto con il proprio corpo trasformato.
Inoltre, la crescita del feto nel grembo materno impone gradualmente un rallentamento dei ritmi, promuovendo momenti di pausa e di riposo. Fermarsi concede l’occasione di “stare” nelle proprie emozioni, mettendosi in ascolto delle sensazioni nel qui e ora. Tale attività consente una maggior conoscenza e gestione delle attivazioni emotive, con risvolti positivi sul benessere tanto della mamma quanto del bambino. A tal fine, può essere utile ritagliarsi dei momenti, ricorrendo anche a esercizi di rilassamento, di mindfulness o di respirazione, per focalizzare l’attenzione sul proprio corpo aumentando la consapevolezza sul suo stato di benessere, sui suoi segnali e sui suoi bisogni.
La relazione con il bambino: un legame che si instaura nel grembo materno.
Il corpo in gravidanza assume un ruolo centrale anche nella conoscenza e nella relazione con il proprio bambino. Nella mente materna, infatti, la percezione dei primi movimenti del bambino favorisce lo sviluppo e l’arricchimento di fantasie relative all’immagine del figlio in arrivo che porranno le basi della loro relazione. In particolare nel secondo e terzo trimestre della gravidanza, il feto inizia a percepire il mondo e a conoscere e riconoscere la figura materna. Il bambino in utero percepisce già le emozioni della madre e si mostra sensibile a stimoli sensoriali uditivi, gustativi, visivi e tattili.
Il grembo materno rappresenta una porta di comunicazione con l’esterno. È proprio attraverso questi sensi che entrambi i genitori possono comunicare col bambino, facendogli percepire la loro presenza. Alla luce di queste scoperte relative alle precoci competenze fetali può essere utile, per i genitori, interagire con il bambino: attività come accarezzare la pancia, parlare al feto, leggere ad alta voce, suonare canzoni possono avere ricadute positive sulla costruzione del loro legame.
Attaccamento prenatale
Il legame che si crea fin dal concepimento viene definito da Cranley (1981) “attaccamento prenatale”, ovvero quel particolare legame che i genitori sviluppano durante le fasi della gravidanza verso il bambino in arrivo e che comprende le manifestazioni comportamentali e il coinvolgimento affettivo verso il feto. La qualità dell’investimento affettivo prentatale influisce sulla successiva relazione di attaccamento genitore-bambino, che ha la funzione biologica di proteggere il bambino e la funzione psicologica di fornire sicurezza.
La qualità del legame di attaccamento, come dimostrato da numerose ricerche, impatta a sua volta sullo sviluppo futuro del bambino, sulle sue capacità cognitive, sulla sua salute mentale, sull’immagine che avrà di sé e sulla formazione di future relazioni.
Tra i fattori che possono contribuire alla buona qualità di tale legame annoveriamo lo stato emotivo e mentale della madre durante la gravidanza. La presenza di sintomi di depressione e ansia può infatti influenzare il benessere materno post-natale e, di conseguenza, la cura e la relazione instaurata nei mesi successivi con il proprio neonato (Milgrom, 1999). In tale delicato momento di vulnerabilità, ricevere un supporto emotivo e pratico da parte del partner o di altre figure significative (familiari e amici) può ridurre il carico di stress materno e fungere da fattore protettivo per il benessere della diade madre-bambino.
Rivolgersi a uno specialista
Diventare genitore costituisce un intero processo e non un singolo evento: necessita di uno spazio e di un tempo per essere costruito e compreso. Tale processo offre ai futuri genitori la possibilità di confrontarsi con le proprie sensazioni, emozioni e pensieri.
Se il disagio percepito in riferimento ai cambiamenti della gravidanza dovesse essere significativo, persistente e invalidante per il proprio benessere e la quotidianità è importante rivolgersi a uno specialista, al fine di acquisire una maggior conoscenza e consapevolezza di sé e dei propri vissuti. Ciò consentirà di proteggere non solo sé, ma anche il proprio bambino.
Articolo a cura della dr.ssa Bonanomi Giulia – Centro Psicologia Monza Brianza
FONTI
- Bowlby, J. (1989). Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Cassidy J., Shaver P. (1999). Manuale dell’attaccamento. Roma: Fioriti, 2010.
- Cranley, M. S. (1981). Development of a tool for the measurement of maternal attachment during pregnancy. In Nursing research, 30, pp. 281-284.
- Pellai A. (2013). L’attesa. Il percorso emotivo della gravidanza. Trento, Erikson.