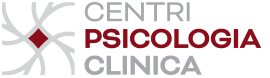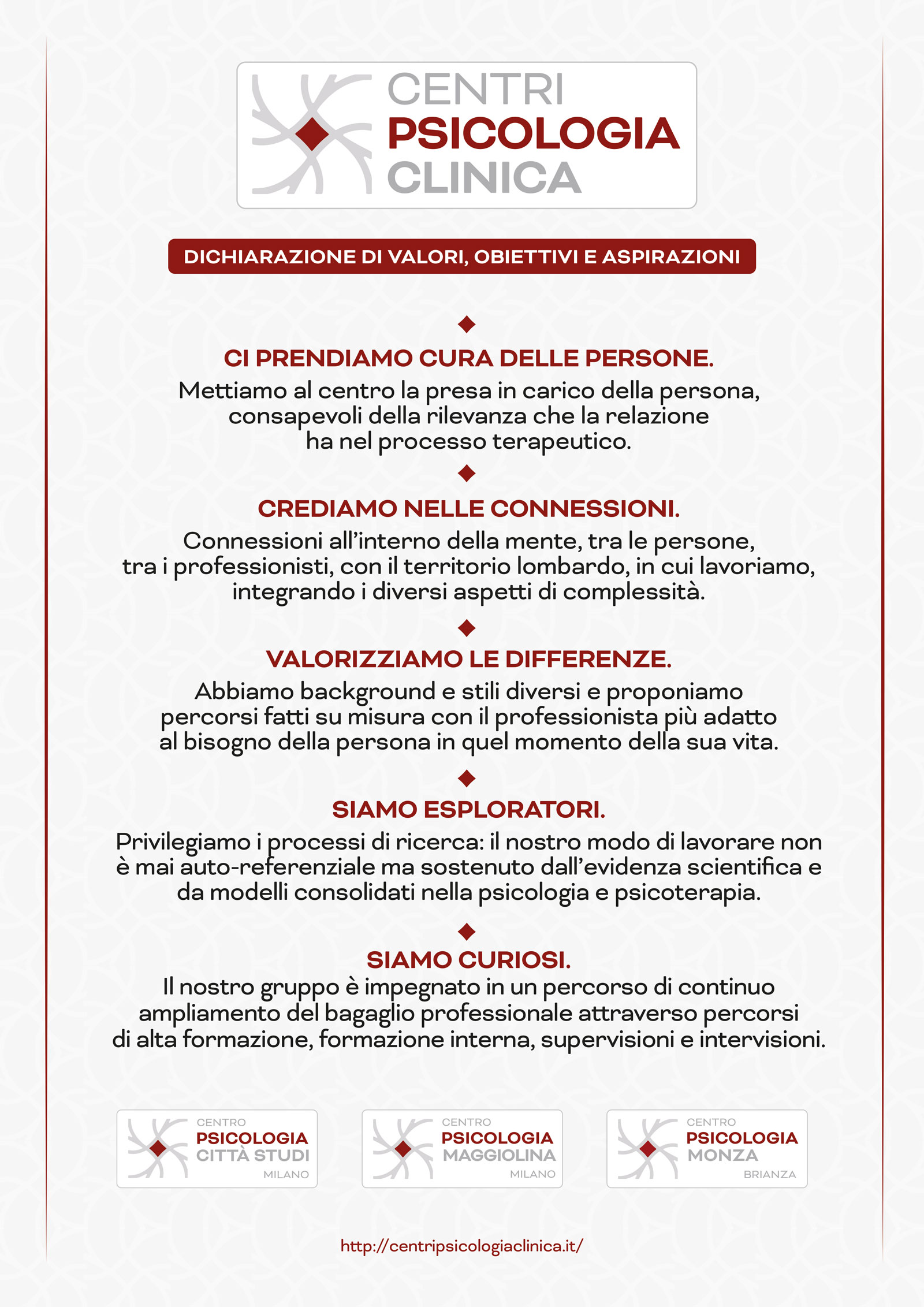La genitorialità rappresenta un viaggio complesso intriso di emozioni e trasformazioni profonde. Nella nostra mente tutti abbiamo un’idea, magari vaga o confusa, di come potrebbe essere per noi: ci si immagina davanti al famoso test di gravidanza positivo su di giri, euforici; si pensa al momento in cui verrà condiviso con il partner, con la famiglia, con gli amici, le facce felici, i momenti di gioia. E a volte ci si sposta ben più avanti sognando il proprio bambino appena nato, lattante o già grandicello. Si fantastica su piccoli o grandi particolari, sull’aspetto fisico o le qualità caratteriali; si raffigurano momenti di famiglia, che tipologia di genitori si sarà e molto molto altro. Quasi sempre quello che accomuna queste fantasie ad occhi aperti è la presenza di un immaginario positivo e perfetto. Ma è sempre così?
Una mappa su misura
Già dalle primissime fasi del viaggio nella gravidanza è possibile che le cose non seguano la traiettoria immaginata. Infatti, non sempre davanti a un test di gravidanza positivo la reazione è quella che ci si aspetta o che si vorrebbe provare. Le emozioni potrebbero essere travolgenti, intense e confuse. È possibile sentirsi ambivalenti o spaventati, tristi, preoccupati e molto altro. Oppure non provare niente, una sorta di vuoto emotivo.
Realtà vs. aspettative
Questi sentimenti non previsti possono creare un senso di spaesamento, soprattutto in presenza di una gravidanza ricercata e voluta. Oltre all’aspetto affettivo possono essere presenti anche reazioni cognitive, ad esempio il chiedersi continuo se si è presa la giusta decisione, e comportamentali conflittuali come l’incostanza nel prendersi cura di sé e del feto. Questi vissuti possono non essere circoscritti ad un periodo limitato nel tempo, ma accompagnare in modo fluttuante il periodo della gravidanza e del post parto. Se non vengono percepiti e accolti o addirittura vengono negati e svalutati, potrebbero avere un impatto anche sulla relazione genitore-bambino (Koletzko et al. 2015).
Le domande “Ma com’è possibile? L’ho desiderato così tanto, perché mi succede questo?” possono sorgere spontaneamente. Una prima spiegazione è da ricercarsi nella narrazione idealizzata e, sovente, irrealistica della tematica della gravidanza e della genitorialità che concorre a creare a sua volta delle aspettative stereotipate nei futuri genitori. Vari sono i fattori che influenzano questa dinamica, ma uno di particolare interesse può essere ricercato nel ruolo del background culturale e dei media.
Il ruolo dei media…
I media spesso forniscono un’immagine della gravidanza rigidamente codificata: le future mamme sono radiose e piene di gioia, mentre i futuri padri sono orgogliosi e protettivi, pronti ad assecondare i desideri della partner. Gli spot pubblicitari, la televisione e le riviste mostrano quasi esclusivamente esempi di persone felici, sorridenti e in perfetta forma fisica. Le pubblicità per prodotti dedicati a questo pubblico, come i prodotti per l’infanzia o per la cura di sé, dipingono una realtà idilliaca di maternità, con famiglie contente e armoniose (Luce et al., 2016).
Le aspettative possono anche estendersi alla genitorialità stessa. L’idea di essere un genitore amorevole, competente e in grado di rispondere perfettamente alle esigenze del bambino può essere dominante. La cultura popolare e i media spesso ritraggono genitori che gestiscono senza sforzo ogni aspetto della cura del bambino, di sé stessi, della coppia e anche del proprio lavoro enfatizzando i momenti gioiosi e minimizzando le difficoltà. Tuttavia, queste rappresentazioni non tengono conto delle sfide emotive, fisiche, psicologiche e pratiche che i genitori possono incontrare lungo il percorso (Nomaguchi & Milkie, 2010).
… e quello dei social
Anche il ruolo dei social media è pregnante nella creazione di un modello “giusto” di gravidanza e genitorialità. Digitando su una qualsiasi piattaforma parole chiave come gravidanza (pregnancy) o genitorialità (parenthood) si viene sommersi da migliaia di immagini o video di donne, uomini, futuri o neo genitori ottimisti, super organizzati e disposti ad elargire consigli pratici o teorici su ogni cosa. Dai video di fitness in gravidanza alle incredibili trasformazioni fisiche pre e post-parto, passando per indicazioni alimentari e modi di vivere il parto, finendo su diversi modelli educativi per allevare figli autonomi, coraggiosi, affettuosi, intelligenti…
Sebbene l’opportunità di accedere a una varietà di informazioni possa essere utile in termini di condivisione delle proprie esperienze, portando anche alla creazione di un senso di comunità e supporto tra individui che affrontano simili transizioni di vita, è altrettanto possibile che possa comportare un sovraccarico informativo che può confondere le aspettative personali generando ansia e indecisione nelle scelte riguardanti la gravidanza e la genitorialità. E a volte ecco arrivare una “crisi”.
Diventare genitori: una fase di crisi?
In ambito psicologico una crisi può essere definita come “uno stato di sofferenza così intensa da costituire un punto di svolta decisivo verso un miglioramento o un peggioramento” (Sifneos, 1982).
Secondo Mazzoleni (2004), gli “eventi critici” sono considerati come potenziali catalizzatori di risorse, spingendo all’esplorazione di nuove dinamiche relazionali più adatte alle nuove condizioni di crescita. L’aggettivo “critico” indica il possibile effetto destabilizzante: l’individuo o il sistema potrebbero non essere in grado di affrontare determinati compiti, rischiando di consolidare schemi mentali, modalità relazionali o comportamenti esistenti. Tuttavia, se adeguatamente supportati, potrebbero invece accedere alle risorse interne ed esterne disponibili per creare nuove e più funzionali forme di vita.
La prospettiva di diventare genitori è a tutti gli effetti un evento critico e un punto di svolta cruciale (Bjelica et al., 2018). Oltre al divario tra le proprie aspettative e la realtà, anche le fluttuazioni ormonali, i cambiamenti nel corpo e le ansie legate alla salute del bambino possono generare un malessere psicofisico significativo. Allo stesso tempo, la preparazione alla genitorialità implica un adattamento a nuovi ruoli e responsabilità, che può mettere a dura prova le capacità di gestione dello stress di una persona.
Gli effetti sulla coppia
Nei casi in cui la genitorialità venga vissuta all’interno di una coppia stabile, la crisi può estendersi a entrambi. La nascita di un bambino può alterare l’equilibrio della coppia, introducendo nuove sfide che richiedono adattamento e comprensione reciproca (Cowan & Cowan, 2000) e che comportano, almeno nel breve termine, una diminuzione della soddisfazione coniugale. Questo declino è spesso attribuito all’aumento delle responsabilità, alla riduzione del tempo libero e alla fatica accumulata.
Una delle cose che può venire meno è la comunicazione tra partner. La paura di non sentirsi compresi e accolti, il senso di vergogna o di colpa, il divario tra la realtà e l’immagine idealizzata della gravidanza e della genitorialità potrebbero determinare una difficoltà o addirittura l’impossibilità di esprimere i propri vissuti interni, che vengono quindi taciuti e rafforzati.
Quali strumenti per accogliere un’esperienza unica e irripetibile
La consapevolezza rispetto ai propri vissuti sulla gravidanza e la genitorialità è fondamentale per delineare il campo d’azione del singolo e della coppia. Il primo passo per sostenere questa delicata fase di vita è dunque identificare le proprie credenze, emozioni e aspettative e riconoscere che possono discostarsi dal modello ampiamente diffuso. Si tratta di un’esperienza unica e irripetibile: riconoscere sin da subito stereotipi e idealizzazioni permette di non trovarcisi intrappolati!
In secondo luogo è importante validare e normalizzare i propri vissuti cercando di comprendere che le risposte affettive, cognitive e comportamentali risultano comprensibili se rilette all’interno della storia sia di vita sia contingente. Normalizzare permette alla persona di aprire una strada al dialogo e al confronto all’interno della propria rete familiare, amicale e/o territoriale così da poter cercare un sostegno ove possibile.
Infine, si può provare a sostare nello stato emotivo anche quando viene percepito negativamente o si discosta da quello desiderato. È possibile provare a immaginare le emozioni e i pensieri come delle onde da cui non ci si può allontanare, ma che è possibile “cavalcare”, “attraversare” o dalle quali è possibile “lasciarsi trasportare”. Come tutte le onde, prima o poi passeranno lasciando di nuovo il mare calmo.
Rivolgersi a uno specialista
Se il disagio percepito in riferimento a questi temi, durante la gravidanza o in una qualsiasi fase della genitorialità dovesse essere significativo e invalidante per il proprio benessere e la quotidianità, è importante rivolgersi a uno specialista per trovare uno spazio di accoglienza non giudicante all’interno del quale palesare il proprio pensiero, esprimere le proprie emozioni e superare la crisi.
Articolo a cura della dr.ssa Elisa Rosa – Centro Psicologia Monza Brianza
FONTI
Bjelica et al. (2018). The phenomenon of pregnancy—A psychological view. Ginekologia polska, 89(2), 102-106.
Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (2000). When Partners Become Parents: The Big Life Change for Couples. Lawrence Erlbaum Associates.
Luce, A. et al. (2016). “Is it realistic?” the portrayal of pregnancy and childbirth in the media. BMC pregnancy and childbirth, 16, 1-10.
Koletzko, S. H., La Marca‐Ghaemmaghami, P., & Brandstätter, V. (2015). Mixed expectations: effects of goal ambivalence during pregnancy on maternal well‐being, stress, and coping. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 7(3), 249-274.
Mazzoleni, C. (2004). Empowerment familiare. Il lavoro psicosociale integrato per promuovere benessere e competenze. Erickson.
Nomaguchi, K., & Milkie, M. A. (2020). Parenthood and well‐being: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 82(1), 198-223.
Sifneos P.E, (1982), Psicoterapia Breve e crisi emotiva, Martinelli, Firenze.